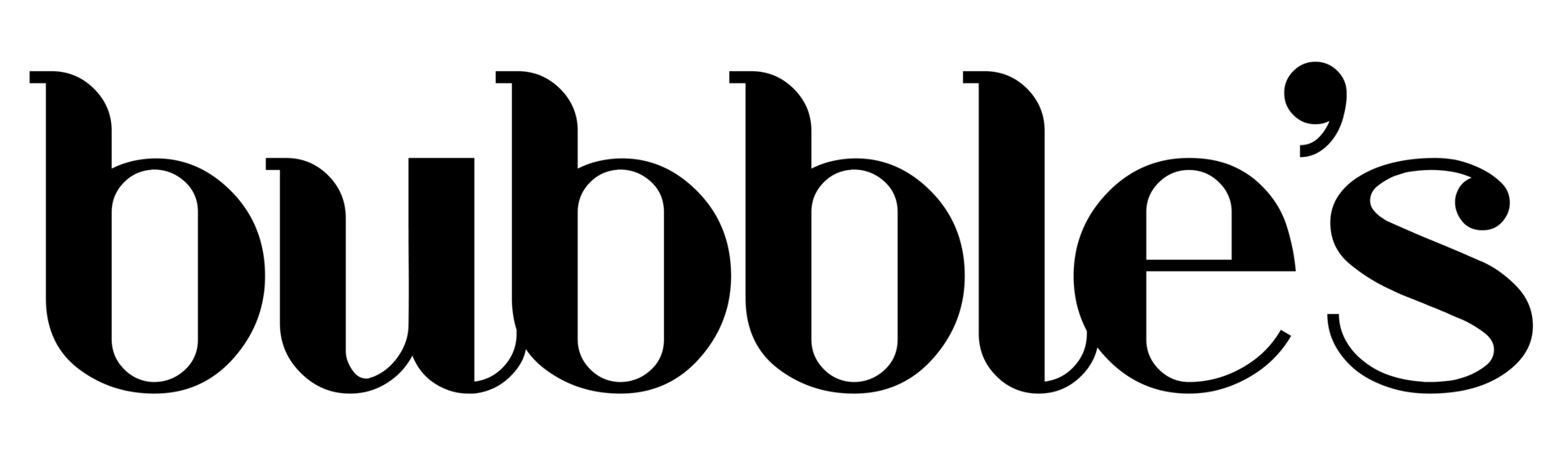Per chi cerca di impostare il proprio lavoro sulla ricerca e valorizzazione della bellezza
Per chi cerca di impostare il proprio lavoro sulla ricerca e valorizzazione della bellezza scoprire che vada sprecata lo rattrista. Del resto è risaputo, come dice un vecchio un proverbio contadino toscano, che “chi ha i denti spesso non ha il pane e chi ha il pane spesso non ha i denti”. Era usato nel tempo in cui risultava un sacrilegio lasciare un pezzetto di pane sulla tavola o non finire ciò che era stato messo nel piatto. Il cibo era un dono della Provvidenza concesso a chi se l’era guadagnato con il lavoro, la fatica e dignità d’animo. Quella signorilità d’animo si evidenziava anche nella povertà che custodiva e dava valore alle cose e alle persone. Gli uomini si sentivano parte di un sistema e non i suoi padroni, si impegnavano e difendevano il senso etico di una magnificenza percepibile anche nelle piccole cose: come locare un olivo, una vite o curare un bosco. Ogni cosa doveva essere posta dove doveva stare perché meglio di quel luogo non ve ne erano altri che potevano custodirla, proteggerla e valorizzarla.

Ricordo che nei giardini di Villa Caruso,
Curioso, gli domandai il perché. La sua risposta mi scioccò. “Quelli sono sassi morti” – “Come morti?” Lo incalzai. Non mi rispose. Ne prese uno e tenendolo in mano dette un colpo non troppo forte, ma deciso, con il martello spaccandolo in due parti. Poi ne prese un altro e ripetendo il gesto lo fece frantumare in tre parti.
Guardandomi, mi disse: “Se questo lo avessi messo lì, nel muro, fra 200 anni lo avrebbe fatto crollare. E io passerei da coglione, perché non ho fatto bene il lavoro come mi è stato insegnato da mio padre”. Giuseppe pensava al tempo e valore del suo lavoro nei decenni a seguire, per questo i sassi vivi erano lì, dove dovevano stare, e gli altri, quelli morti, no.
Ebbi chiaro quanto fosse relativo il valore che io davo al tempo,
a Lastra a Signa, molti anni fa, incontrai un gruppo di ragazzi del carcere minorile di Firenze che seguivano svogliatamente uno stage sull’architettura ambientale organizzato dal comune. Quel corso prevedeva anche lezioni sulla costruzione e riparazione dei muri a secco. Come tutor d’occasione avevano un vecchio, non so se fosse muratore o contadino, non ricordo neanche come si chiamasse, forse Giuseppe. Un personaggio arcigno e silenzioso; un maestro d’altri tempi che attraverso i gesti e la precisone con cui operava, sembrava possedere la saggezza di chi aveva ben chiaro come si fanno le cose. Non diceva nulla. Non si preoccupava della svogliatezza che lo circondava. Credo pensasse che anche quei ragazzi avrebbero dovuto rubare il suo saper fare con gli occhi, come aveva fatto lui con suo padre. Lavorava aggiustando un pezzo di muro a secco che reggeva un terrapieno sopra il quale vi era un filare di olivi. Notai che con un martello, appuntito da una parte e tagliente dall’altra, smussava alcuni sassi dagli spigoli, adagiandoli nell’ingombro giusto, mentre altri, dopo averli presi in mano e soppesati, li gettava su un cumulo di pietre alto poco meno di quello dal quale li aveva tolti.
e la differenza che davo a quella clessidra rispetto a Giuseppe. La cosa sorprendente, però, non era solo questa, ma il valore che assumeva nello spazio temporale quel personaggio che custodiva il valore più intimo di quella bellezza che andavo sempre cercando. Giuseppe era uno scrigno che nascondeva lo splendore del suo lavoro e che rispecchiava, ai miei occhi, l’opera degli scalpelli e dei maestri muratori e di tutte le maestranze e progettisti o artisti che avevano contribuito a costruire cattedrali o battisteri, ponti o castelli.
L’idea stessa che avevo della bellezza si ampliava a dismisura,
scoprendo quanto la stessa scorresse in migliaia di rivoli intorno a me senza che io ne avessi mai presa coscienza. In pochi minuti compresi come le mani, i volti e le anime di quei contadini che avevano contribuito a disegnare le terre italiane in modo michelangiolesco fossero lo specchio di cosa andavo cercando. La bellezza di ogni sasso di quel muro a secco ora si ergeva dentro di me, dandomi la certezza che non sarebbe crollato mai. Quanto tempo avevo perso a cercarla. Non riuscivo a vederla dove si annidava, neanche quando mi si palesava in modo innegabile. Giuseppe, con i suoi sassi vivi e con quelli morti, fu il mio paradigma. Sono passati decenni, e di bellezza ho parlato molto, così come ne hanno parlato in molti. Ma sono ancora in molti a non capire dove si annida. Sembra che nessuno abbia voglia di scoprire dove sia e, neanche ascoltando una poesia o vedendo un gesto d’amore o di fronte al sublime valore di una scultura o di un dipinto, di un tempio, di monumento o di un’opera d’arte, riescono a dargli il giusto valore. E non ci riescono perché hanno ricevuto in dono tutto gratuitamente.
La bellezza è un argomento difficilmente governabile perché non inquadrabile nel pragmatismo o nel raziocinio, ma nell’animo; la stessa sua fruibilità fa paura poiché richiede un costate miglioramento di ciò che siamo. Come dice il mio amico Giuseppe Leone, grande fotografo siciliano, e grande conoscitore dell’essere umano: “La bellezza è stata inventata da altri, da quelli che l’hanno edificata e da quelli che l’hanno raccontata e non è opera nostra”.
Andrea Zanfi
Foto: Bubble’s